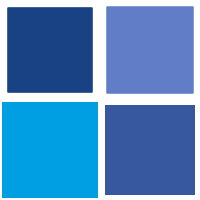Proteggere ad ogni costo?
Cresce il clamore, in questo anno elettorale, sia in Europa che negli Stati Uniti: proteggeteci! A seconda dei gruppi: dall’inflazione, l’immigrazione, le interferenze straniere, il “wokismo”, il razzismo, la guerra, il cambiamento, il declassamento…
Un appello al quale i repubblicani US rivolgono una particolare attenzione. Contrastando con il liberismo degli anni di Reagan, una rinnovata forma di protezionismo ha ora il vento a favore non solo contro l’immigrazione ma anche contro la concorrenza internazionale, cinese in particolare. Al riguardo, il programma di Trump è estremamente chiaro come emerge dall’“Agenda 47” pubblicata sul suo sito, analizzata tra l’altro dalla Deutsche Bank. Il programma prevede tasse universali del 10% sulle importazioni di tutti i beni e servizi; un aumento delle tasse nei confronti dei Paesi che ne impongono agli Stati Uniti, onde raggiungere un livello di reciprocità; la revoca dello status di “nazione più favorita” di cui gode la Cina, accompagnata da nuove tasse sulle importazioni tipicamente del 50 o del 60%; oppure la reintroduzione delle tasse sulle importazioni di acciaio e nuove tasse sui prodotti europei, in particolare le automobili, spesso tedesche.
Benché far approvare tutte queste misure dal Congresso possa risultare difficile, qualcuna potrebbe comunque essere attuata, tanto più se in linea con quelle adottate sotto la presidenza Trump nel 2018-2019.
Quali conseguenze dunque per gli americani e, di riflesso, per l’economia globale?
Possono sperare, in positivo, nella rilocalizzazione di alcune industrie e servizi che acquisirebbero automaticamente maggiore competitività. È l’argomento elettorale principe: più industrie locali e quindi maggiore occupazione. Aumenterebbero automaticamente anche gli introiti federali. In un contesto di disavanzo di bilancio cronico e di elevati tassi di interesse, questa argomentazione riveste un peso significativo. Stando alla Tax Foundation, il gettito generato ogni anno dalle nuove tasse potrebbe attestarsi a 300 miliardi.
Tutto però ha un costo: non si possono eludere le conseguenze negative del protezionismo. In primo luogo, l’inflazione subirebbe inevitabilmente un’impennata per via delle tasse sui beni e servizi importati. Gli stessi produttori americani subirebbero l’inflazione quando ricorrono alle importazioni, così come i consumatori di beni importati. Inoltre, la minore concorrenza derivante dalla penalizzazione delle imprese straniere consentirebbe a quelle locali di disporre di margini più ampi per incrementare i prezzi. Del resto, non necessariamente avrebbero altra scelta visto che il costo del lavoro americano è ben superiore a quello della maggior parte dei partner commerciali. I Paesi interessati non resterebbero naturalmente a guardare e, a loro volta, potrebbero introdurre delle tasse sulle importazioni, indebolendo le esportazioni statunitensi e rafforzando in questo modo la spirale inflazionistica. Il dollaro, infine, potrebbe rafforzarsi dato che il flusso di dollari in uscita dal Paese sarebbe a priori inferiore. Anche in questo caso ne risentirebbero le esportazioni statunitensi, ancorché poco significative in termini di PIL.
Emerge chiaramente, da queste proiezioni, l’effetto profondo che l’eventuale attuazione del programma di Trump avrebbe sull’economia globale. Certo, la rilocalizzazione di una parte dell’economia potrebbe favorire i lavoratori americani che non hanno però particolarmente bisogno di un’ancora di salvezza visto il basso tasso oggi di disoccupazione. Ma soprattutto, in quanto nazione di consumatori, il Paese andrebbe incontro a una maggiore inflazione e sarebbe probabilmente penalizzato sul piano delle esportazioni. Quindi meno crescita e più inflazione… il costo del protezionismo non è trascurabile. Gli elettori sono disposti a pagarlo? La risposta il 5 novembre 2024.
Rédaction achevée le 31.05.2024, par Alexis Bienvenu, Fund Manager, LFDE
Telex
Tutti al lavoro! Risultato migliore del previsto per il già basso tasso di disoccupazione nell’Eurozona ad aprile che si attesta al 6,4% rispetto al 6,5% del mese precedente. Un nuovo minimo storico dalla creazione dell’Unione monetaria. Uno dei Paesi che meglio riflette questo andamento è l’Italia, dove il tasso è sceso al 6,9% dal 7,1% di marzo, il livello più basso dalla fine del 2008 a conferma dello stato di salute relativamente buono in questo momento dei Paesi meridionali dell’Eurozona. Infatti, se il mercato del lavoro US mostra segni di debolezza è vero il contrario per l’Eurozona. Ed è un punto tanto più positivo per l’Eurozona visto che i segnali di ripresa dell’attività stanno aumentando e la BCE sembra pronta a tagliare i tassi. Le stelle si starebbero nuovamente allineando a favore dell’Eurozona?
Facce lunghe in Cina. Deludono gli ultimi dati sul ritmo dell’economia cinese, proprio quando il mercato stava iniziando a recuperare un po’ di fiducia. In effetti, l’indice PMI manifatturiero ufficiale di maggio è sceso a 49,5 da 50,4 il mese scorso, indicando una leggera contrazione e deludendo le aspettative del mercato a causa di un rallentamento della produzione e dei nuovi ordini (49,6). Il PMI per l’edilizia rimane a un livello elevato, a 54,4, inferiore tuttavia a quello del mese scorso (56,3). Infine, delude anche il PMI dei servizi, attestandosi a 51,1 contro 51,5 previsto, in leggera flessione rispetto al mese scorso (51,2) per via in particolare del calo dei nuovi ordini (46,9). Nel complesso, la traiettoria rimane fragile anche se il Fondo Monetario Internazionale ha appena alzato le sue aspettative di crescita per la Cina portandole al 5% per l’anno.